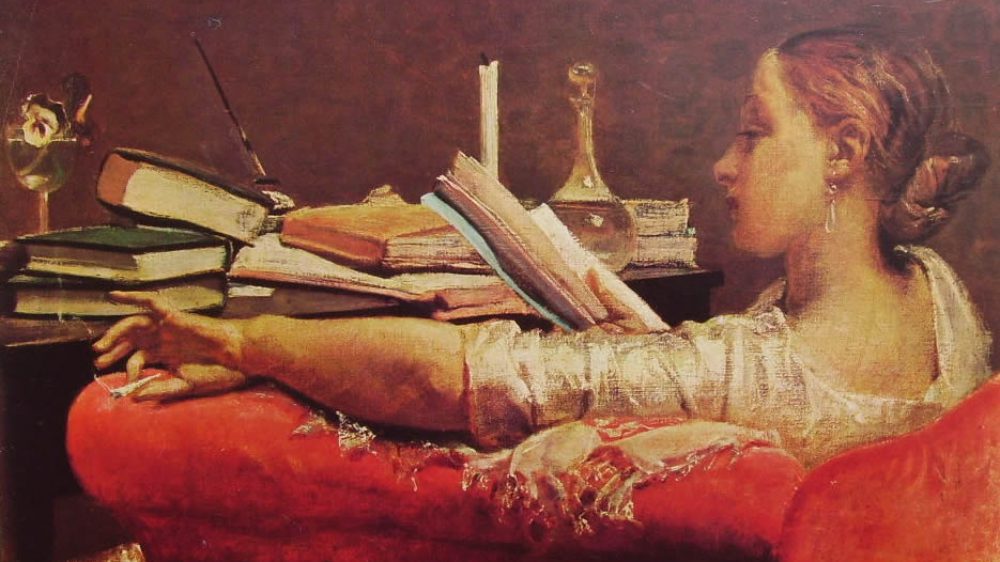Un brano dal “Ghibellino di Modoezia” di Valeriana Maspero per chi ha voglia, pazienza e tempo per leggere.
<Ma proprio in quel periodo anche a Mediolano, città finora risparmiata, era comparsa la peste.
Si diceva che fosse un castigo di Dio per gli spregiudicati Visconti. Una delle prime vittime era stato l’arcivescovo Roberto. Ma Bernabò reagì subito, promulgando una ordinanza con le disposizioni per combattere il contagio: controlli alle porte, roghi, norme generali d’igiene per le strade e le piazze, leva obbligatoria di medici, infermieri e becchini pubblici. Lui trattava la peste come uno dei suoi nemici usuali: non aveva detto che anche Dio nelle sue terre poteva fare solo quello che voleva facesse?
E alla fine, in estate, la morte nera era comparsa anche a Modoezia. Era arrivata da Mediolano, con i soldati e i cacciatori che si davano il cambio al castello di Bernabò. Il consiglio dei Trenta aveva ordinato di chiudere tutte le porte della città e di accendere fuochi sulle mura, come avevano suggerito i dottori dell’ospedale di San Gherardo, per impedire al male di entrare sotto forma di miasmi putridi. Ma non era bastato.
Quando la peste era arrivata a Mediolano, anni e anni di epidemia in tutta Europa avevano contribuito a raffinare le cure, anche se non si era trovato alcun rimedio veramente efficace. Una cosa almeno i dottori avevano capito: che il contagio era un fluido invisibile che passava da persona a persona. Il medico Tomaso del Garbo affermava che era l’aria a portare il contagio e quindi se si presentava in casa la malattia, la prima cosa da fare era quella di cambiare aria, nel senso di andarsene proprio via dalla città. In seconda battuta il dottore bolognese raccomandava di non respirare l’aria degli ammalati, non avvicinandosi a essi e alle loro cose. Ma nessun medico immaginò mai che tutto aveva origine dal morso delle pulci dei ratti.
Tuttavia bisogna riconoscere che quei saggi erano stati fin troppo intelligenti. Avevano capito che esisteva un contagio e come il morbo si diffondeva tra la gente. Ma anche se avessero indovinato l’origine della malattia, non avrebbero avuto medicine in grado di eliminarla. I dottori, che usavano i rimedi più vari e fantasiosi, non sapevano che le forme di contagio erano tre – dal morso della pulce o del ratto infetto, alla tosse del malato, al toccarsi con le dita contaminate le mucose di
bocca o naso – ma avevano individuato le tre forme di peste che ne conseguivano.
A Mediolano l’ordinanza Visconti conteneva tutte le indicazioni sanitarie più aggiornate. In tutto il territorio i cittadini tenevano puliti i loro spazi, inchiodavano porte e finestre delle case infette, non si potevano comprare e vendere panni di lino e di lana usati. E l’epidemia a Mediolano e dintorni non fu così violenta come all’estero o in Toscana nel fatidico 1348, quando morivano quasi mille persone al giorno.
A Modoezia per via delle restrizioni sugli abiti usati, gli affari andavano a gonfie vele per lanaioli e tessitori, come Renzo dei Morigi. E per l’aumento dei morti anche ai becchini della famiglia Zevi.
Pur se non comparvero fosse comuni e quartieri infetti tutti sprangati, tuttavia la città si spopolò. Chi poteva era scappato nelle ville o nelle cascine dei parenti della Brianzia Martesana.
I Pelucchi – Ghino, Duccio e Vanisio – si chiusero nella loro salubre villa a sei miglia da Mediolano e si diceva che passassero il tempo nella lussuria più sfrenata, a somiglianza della compagnia fiorentina che il frate Boccaccio aveva immortalato nella sua celebre opera. In effetti molti, davanti alla prospettiva di poter morire da un giorno all’altro, si davano alla bella vita del cibo e del sesso senza freni.
Al contrario altri si rifugiavano nelle fede e nella preghiera di riparazione, credendo alla chiesa che riteneva la peste un castigo divino. Fu la scelta di Bartolomeo Zanata che, dopo la morte del vecchio Elia, donò tutte le opere d’arte che il padre aveva collezionato al santuario di San Giovanni e si ritirò nel monastero di San Pietro di Civate a fare penitenza. In effetti dei monaci di quell’abbazia nessuno morì di peste.
Franzio Baldironi con la sua numerosa famiglia tornò a rifugiarsi nel grande podere che aveva sulle sponde orientali del Lario. Qui nacquero i suoi nipoti e lui non rientrò più a Modoezia. I Bellinzoni se ne andarono a Desio, dove avevano comprato una villa con prati e stalle. I Montebretti chiusero le loro case di Modoezia e con i carri si trasferirono nelle cascine di Monte Vecchia, dove avevano poderi coltivati a uva. I Riboldi si ritirarono nella valle del Curone, presso la tenuta agricola di certi loro parenti, ma tornarono in città dopo il primo periodo di quarantena.
Gli Scotto erano invece partiti per Venezia, dove un loro zio aveva un palazzetto sul canal Grande: lì però la peste imperversava, dicevano che le gondole erano state tutte colorate di nero per il lutto delle numerose morti e nessuno capì mai perché quella famiglia fosse andata là.
I Gualteri si divisero: metà della famiglia con il giovane Piolo comprò una cascina alla rocca del Tignoso in Martesana, l’altra metà guidata dal notaio Gualterio partì con i carri diretta a ovest, verso il mare e la Francia. I primi tornarono poi in città, dei secondi non si seppe più nulla.
Ma ci furono anche quelli – e furono la maggioranza – che rimasero in città, o perché erano troppo poveri per spostarsi, o perché non avevano parenti che potessero ospitarli, o infine per scelta.
Baldo Buzzelli e Atto Dell’orto ad esempio erano rimasti, come pure Bonco Morigi. Erano in fondo fatalisti. Non avevano fiducia nei dottori, spesso contraddetti dai fatti. In definitiva, non volevano lasciare il loro mondo.
La casa Morigia si era spopolata. Molti servi se n’erano andati. I figli di Selvina – il notaio Rocco con la moglie Benetta e i gemellini, e Onorio con Nicoletta Bellioni – erano partiti per Casate Nuovo di Brianza, ospiti nella villa della sorellastra Simonetta e del suo marito Mantegazza. Renzo stava quasi sempre chiuso nei capannoni al Carrobbiolo. La vecchia Selvina era rimasta sola con una domestica appena. Spesso stava con Simone, il figliolo di Renzo e ogni tanto veniva a trovarla anche Belfiore, la figlia di Secondo e Colomba. Questi due erano restati in città e stavano anche loro ben serrati nella loro trattoria, piena di viveri, a coltivare l’orto e accudire gli animali.
Anche Bonco e la Bella non volevano lasciare la loro casa. Prima venivano spesso a trovarli Astinola e Maggio con il piccolo Nani, che era ancora il loro giocattolo preferito. Ma dall’inizio della epidemia le loro visite si erano diradate: tutti preferivano avere meno contatti possibili, specie se in casa c’erano bambini piccoli.
Allora Bonco era andato lui a trovarli e aveva fatto una proposta.
«Qui nel palazzo del Pratomagno siete insieme a tante altre famiglie. Troppa gente che va e che viene. Il contagio è più facile, lo dicono anche i dottori. Tornate ad abitare con noi. La casa è grande e si è svuotata. Staremo bene. È più prudente.»
Maggio accettò.
«Mi sembra una buona idea. Ci chiuderemo in casa a raccontarci storie come consiglia il libro del Boccaccio fiorentino.»
Valeriana Maspero – Ghibellino di Modoezia
Rispondi